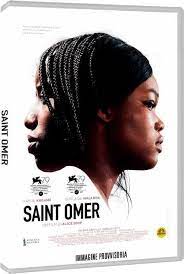Una nuova recensione di Claudio Cherin.
Laurence Coly (Guslagie Malanga) è la donna di origine africana infanticida, il cui operato ha sconvolto la città francese, che dà il titolo al film.
La giovane donna ha deliberatamente abbandonato la sua bambina di quindici mesi al mare. In una notte fredda. Per liberare se stessa e la bambina dal malocchio. Alla domanda sul perché lo abbia fatto, sul perché abbia ucciso la sua bambina, la giovane donna non sa come risponde. Anzi, spera che il processo a cui è sottoposta l’aiuterà a capire. E a comprendere quanto accaduto. Dice questo sotto lo sgomento del pubblico in aula e l’incredulità del giudice, pronti a giudicarla colpevole.
Fin da subito, Laurence si rivela, impenetrabile e contraddittoria. La sua deposizione è nitida e glaciale, è troppo accurata e dettagliata per essere estranea ai fatti. Nel suo racconto c’è qualcosa di mostruoso e inquietante che nessuno, al suo posto, direbbe.
La sua vita sembra quella di un’emarginata, anche se ha frequentato l’università e ha studiato sia in Senegal sia in Francia.
C’è qualcosa che l’ha portata a rendesi invisibile e ostile al mondo. La stessa maternità e la nascita della bambina sono stati tenuti segreti agli amici, ai conoscenti e anche al più maturo (per età) compagno.
Non la pensa così Rama (Kayije Kagame) ‒ l’occhio attraverso il quale entriamo in questa storia ‒ che rimane perplessa e turbata da quello che sente dire alla giovane donna.
Quanto emerge nelle fasi del processo la turba e sembra schiacciarla. Rama, infatti, è figlia di immigrati africani, e si trova in quel tribunale per scrivere degli articoli per l’editore con cui collabora.
E, anche se è ben integrata, insegna letteratura francese all’università e sta scrivendo un libro sul mito di Medea, non sembra aver fatto i conti con il nodo che una storia di migrazione ‒ per quanto non ci siano stati eventi traumatici ‒ porta con sé.
Rama vive, ha sempre vissuto con questo nodo, che il processo le mostra per la prima volta. Nella sua famiglia la madre, che pure ha retto abbastanza bene (ha trovato un lavoro, ha provveduto da sola a se stessa e ai suoi figli), ha portato una ferita intima. La migrazione l’ha distrutta e per questo ‒ si capisce bene dai flasback brevissimi che si susseguono rapidissimi nel film ‒ è stata una madre fredda e incapace di donare alla propria figlia l’affetto che desiderava, perché schiacciata dal mondo che l’ha ospitata e nostalgica della comunità che ha abbandonato, come sostiene il compagno di Rama.
Contrastanti sentimenti si susseguono in Rama, che assiste a un processo in disparte.
Preoccupata oltre ogni limite: perché sa che con quella donna ha molto in comune. Più di quanto possa immaginare. Non condivide solo la vita (è una donna), non solo le sue origini, ma anche il destino: Rama, come l’imputata, sta per affrontare la sua prima gravidanza.
Alice Diop, l’autrice di Saint Omer, lascia emergere la fragilità dell’imputata, ma anche gli eccessi, le allucinazioni, la gelosia verso un compagno troppo vecchio e troppo assente, così come la maledizione lanciata dai suoi antenati o forse dai fantasmi della sua coscienza.
È, dunque, nelle forze oscure, nella stregoneria che Laurence invita la corte a cercare l’origine del suo gesto. Questa spiegazione alimenta la linea di difesa dell’avvocato, guida il film, sospeso tra due culture (quella francese e quella senegalese), e porta alla luce il conflitto tra le due identità e tra due possibili modi con cui convivere: l’accettazione e il rifiuto delle sue molteplici eredità.